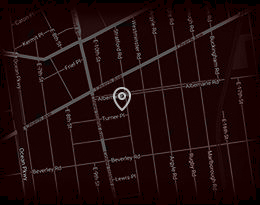Michele Mariotti: Francis Poulenc - "Gloria"

Giovedì 8 maggio alle ore 20 - in Sala Zubin Mehta - il maestro Michele Mariotti torna alla guida dell’Orchestra e del Coro del Maggio Musicale Fiorentino.
In programma le musiche di Wolfgang Amadeus Mozart, Igor Stravinskij e Francis Poulenc.
Solisti nel Gloria, di Poulenc, il soprano Emőke Baráth e il tenore Luca Tamani.
Il concerto sarà trasmesso in differita su Rai Radio 3
Firenze, 6 maggio 2025 – Continuano gli appuntamenti sinfonici nell’ambito dell’87ª edizione del Festival del Maggio Musicale Fiorentino.
Giovedì 8 maggio, alle ore 20, in Sala Mehta, il maestro Michele Mariotti torna a dirigere l’Orchestra e del Coro del Maggio a distanza di quasi 10 anni dal suo ultimo impegno fiorentino. Il maestro del Coro del Maggio è Lorenzo Fratini.
Il concerto si apre con la Sinfonia in sol minore K. 183 di Wolfgang Amadeus Mozart che il genio di Salisburgo compose nell’autunno del 1773. Questa sinfonia è nota anche come la Piccola, per distinguerla dalla Grande K. 550 (nella stessa tonalità): si dice che fu scritta in appena due giorni, anche se è probabile che Mozart attendesse alla composizione di più opere contemporaneamente e questo motiverebbe la distanza di due giorni dalla data con la quale è firmata rispetto alla precedente Sinfonia K. 182. Segue una delle più amate composizioni di Igor Stravinskij, Jeu de cartes: nel 1935, mentre si trovava negli Stati Uniti, Stravinskij ricevette l'invito da Edward Warburg e Lincoln Kirstein per scrivere una partitura per l’American Ballet, da poco formatosi. Il musicista decise di realizzare un balletto sul tema del gioco poiché era sempre stato attirato dal gioco d'azzardo fin dalla sua infanzia e spesso ricordava l’impressione lasciatagli da una vacanza presso una località termale tedesca, dal suo casinò e dai giocatori.
Chiude il concerto il Gloria in sol maggiore per soprano, coro e orchestra di Francis Poulenc. Fu eseguito per la prima volta a Boston gennaio 1961 con la direzione di Charles Münch e solista il soprano Adele Addison, riscuotendo un immediato successo, nonostante Poulenc venne fatto bersaglio di alcune critiche per il suo modo “spregiudicato” di trattare la materia sacra. Sul palco della sala Mehta, nell’esecuzione del Gloria, Emőke Baráth, soprano, al suo debutto sulle scene fiorentine, e Luca Tamani, tenore e artista del Coro del Maggio.
Il maestro Mariotti, che al Maggio ha debuttato con Snow White di Luigi Zaninelli nella primavera del 2006, si è diplomato in composizione al Conservatorio Rossini della sua città, Pesaro, dove ha studiato direzione d’orchestra sotto la guida di Manlio Benzi. Contemporaneamente si è diplomato in direzione d'orchestra presso l’Accademia Musicale Pescarese con Donato Renzetti. Insignito del 36° Premio Abbiati come Miglior direttore d’orchestra, è stato ospite dei principali teatri e festival italiani ed internazionali fra cui La Scala di Milano, l’Opéra di Parigi, la Wiener Staatsoper, la Royal Opera House Covent Garden di Londra, la Bayerische Staatsoper di Monaco di Baviera, la Deutsche Oper di Berlino, il Festival di Salisburgo e il Rossini Opera Festival di Pesaro. Dal 2008 è stato Direttore principale e poi Direttore musicale del Comunale di Bologna, teatro in cui ha diretto numerosi concerti sinfonici e decine di produzioni operistiche, tra cui La bohème con la regia di Graham Vick, che ha vinto il premio della critica musicale “Franco Abbiati” come miglior spettacolo del 2018.
Il concerto:
Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonia in sol minore K. 183
Mozart realizzò la Sinfonia in sol minore K. 183 nel 1773 all’età di diciassette anni. Per molti commentatori è considerata la Sinfonia della svolta, il primo dei molti capolavori nel genere che da lì in poi sarebbero stati vergati dal talentuoso musicista salisburghese. L’estate di quell’anno Mozart l’aveva trascorsa a Vienna, dove aveva avuto la possibilità di conoscere le sinfonie di Haydn in tonalità minore, rimanendo fortemente impressionato. Al suo ritorno a Salisburgo decise così di mettere a frutto le sue nuove conoscenze realizzando la Sinfonia in sol minore, il cui carattere impetuoso e passionale la distingue nettamente dalle altre sinfonie composte in quel periodo. La Sinfonia K. 183 si divide in quattro movimenti legati da un'intensa e malinconica espressività. Sin dalle prime battute dell’Allegro con brio si percepisce un clima carico di pathos che non si stempera nel seguente Andante, anch’esso animato da inquietudine melodica. Il Minuetto, sempre in sol minore, regala un momento gioioso solo nel Trio (in sol maggiore) affidato ai soli fiati, mentre l’Allegro finale riporta in primo piano l’energia focosa e i bruschi contrasti dinamici già presenti nel primo movimento.
Igor Stravinskij
Jeu de cartes
Jeu de cartes, “balletto in tre mani” di Igor Stravinskij fu composto nel 1936 su richiesta del coreografo e impresario Lincoln Kirstein per l’American Ballet e debuttò il 27 aprile 1937 a New York con la coreografia di George Balanchine. L’azione del balletto descrive una partita di poker, uno dei giochi preferiti di Stravinskij, durante la quale il malizioso jolly, che si considera invincibile per la sua capacità camaleontica di trasformarsi in qualsiasi carta, domina il gioco nelle prime due mani; ma nella terza e ultima mano verrà inaspettatamente sconfitto da una scala reale di cuori. Opera di disimpegno, 'Jeu de cartes' rappresenta per Stravinskij la pura essenza del divertissement musicale che gli consente di giocare liberamente con materiali musicali del passato da scomporre e poi assemblare con ironia e virtuosismo ritmico in un variopinto puzzle sonoro. Valzer e Galop viennesi, echi di Čajkovskij, musica di fiera, la citazione scoperta della sinfonia del Barbiere di Siviglia di Rossini, sono solo alcuni degli elementi eterogenei che vengono piegati dalla fantasia del compositore russo in un’opera brillante e dal fascino ritmico travolgente.
Francis Poulenc
Gloria in sol maggiore per soprano, coro e orchestra
Nel 1959 la Fondazione Koussevitzky contattò Francis Poulenc per realizzare una sinfonia in onore di Sergej Koussevitzky e di sua moglie Natalia. Ma il compositore francese replicò che la sinfonia non era il suo genere ottenendo quindi libertà di scelta sul brano da comporre. Nacque così il Gloria per soprano, coro e orchestra che fu completato nel 1960 ed eseguito per la prima volta a Boston nel gennaio dell’anno successivo. Il testo liturgico del Gloria, tratto dalla messa, assume nell’opera di Poulenc un’aria gioiosa e scanzonata che fece storcere il naso a molti. A chi biasimò l’eccessiva spregiudicatezza del Gloria, Poulenc replicò dicendo che nel comporlo aveva pensato agli affreschi di Gozzoli nei quali gli angeli tirano fuori la lingua e anche ai seri monaci benedettini che lui un giorno vide intenti a giocare a pallone, rimarcando quel senso dell’umorismo che traspare in tutta la sua produzione, anche in quella sacra. Articolato in sei sezioni, il Gloria alterna momenti di preghiera struggente (nelle sezioni in cui è impegnata la voce del soprano) a esplosioni vocali di esultanza gioiosa. I forti contrasti che caratterizzano lo stile di Poulenc sono declinati nel linguaggio armonico di quest’opera, che affianca spigolose dissonanze ad accordi sontuosi e sinuosi, nelle dinamiche, nell’alternanza di canto sommesso ed enfatiche intonazioni corali; elementi usati abilmente per esprimere una vasta gamma di emozioni, dalla lirica serenità alla gioia più sfacciata.