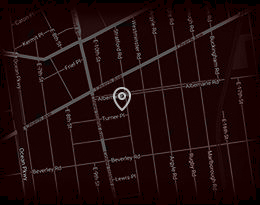Jérémie Rhorer: 20 settembre 2025 ore 20

Sabato 20 settembre 2025 alle ore 20 il maestro Jérémie Rhorer sale sul podio della Sala Zubin Mehta - alla guida dell'Orchestra e del Coro femminile del Maggio Musicale Fiorentino - per il primo appuntamento sinfonico-corale dopo la pausa estiva.
In cartellone “Trois Nocturnes” di Claude Debussy, “Shéhérazade” di Maurice Ravel, “Prélude à l’après-midi d’un faune", sempre di Claude Debussy, e la “Sinfonia in tre movimenti” di Igor Stravinskij.
Solista il soprano Elizabeth Llewellyn.
Firenze, 17 settembre 2025 – Dopo la pausa estiva riprende la programmazione concertistica del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino.
In cartellone, sabato 20 settembre 2025 alle ore 20 in Sala Zubin Mehta, il primo appuntamento con le composizioni di Claude Debussy, Maurice Ravel e Igor Stravinskij.
Sul podio, alla testa dell’Orchestra e del Coro femminile del Maggio Musicale Fiorentino, il maestro Jérémie Rhorer, impegnato inoltre fino al 23 settembre in Sala Grande con le recite de Les pêcheurs de perles di Georges Bizet. Il maestro del Coro del Maggio è Lorenzo Fratini.
Il concerto si apre con Trois Nocturnes per coro femminile e orchestra, composizione firmata da Claude Debussy e basata su alcune poesie tratte dai “Poèmes anciens et romanesques” di Henri de Régnier. Segue uno dei più celebri lavori di Maurice Ravel, Shéhérazade, poema per voce e orchestra che gli fu ispirato dalla lettura dei poemi orientali di Tristan Klingsor: nel corso dell’esecuzione del brano la solista è il soprano Elizabeth Llewellyn, al suo debutto sulle scene del Maggio.
La serata prosegue poi con Prélude à l’après-midi d’un faune - fra le composizioni più conosciute di Claude Debussy il quale trasse ispirazione da un’egloga di Mallarmé, poeta tra i più stimati dal compositore - e si conclude con la Sinfonia in tre movimenti di Igor Stravinskij, composta tra il 1942 e il 1945 e dedicata alla New York Philharmonic Symphony Society.
Parlando del concerto, il maestro Jérémie Rhorer si è soffermato sul programma in cartellone, evidenziando come questo unisca alcuni dei più grandi capolavori della musica francese e dell’influenza che questa musica ha avuto su musicisti quali Igor Stravinskij: “Il programma del concerto del 20 settembre è davvero affascinante, poiché unisce e avvicina tre magnifici esempi della musica francese a un grande compositore come Stravinskij. In particolare, soffermandomi su Debussy e Ravel, credo che siano capaci – con la loro musica – di usare l’orchestra per sfruttare tutti i colori musicali del mondo. Sempre parlando di questo programma mi viene inoltre da sottolineare come il direttore debba essere sempre al servizio del compositore, soprattutto in questi casi. Io lavoro sempre per capire quali fossero le intenzioni del musicista, rispettando la struttura del suo lavoro e cercando di restituire al pubblico l’architettura stessa delle musiche che vengono eseguite”.
Il programma:
CLAUDE DEBUSSY
Trois Nocturnes
Nel 1892 Claude Debussy pensò di realizzare una composizione articolata in tre brani per violino e orchestra dal titolo Trois scènes au crepuscule. Il progetto però non fu portato a compimento e il materiale musicale già composto venne impiegato in un’altra partitura nata tra il 1897 e 1899: Nocturnes, trittico sinfonico per coro femminile e orchestra. A dispetto delle sue abitudini, fu lo stesso Debussy a chiarire il senso del titolo in un testo di presentazione: “Non si tratta della forma abituale del Notturno”, disse, “ma di tutto ciò che la parola contiene di impressioni e di luci particolari.” Una musica che vive non solo nella dimensione del tempo ma anche nell’evocazione dello spazio, dove i frammenti tematici sono sottratti alle leggi della dialettica e trattati piuttosto come macchie sonore. Così in Nuages, il primo dei brani, non vi è traccia di un percorso che segua una logica discorsiva. Il tema principale affidato al corno inglese, su un morbido tappeto d’accompagnamento di clarinetti e fagotti, non conosce sviluppo e suggerisce un trascolorare infinito proprio come il passaggio delle nuvole. In Fètes la musica ha un cambio di marcia: il ritmo si fa incalzante e il discorso assume l’aspetto di un flusso con continui mutamenti di direzione. Nell’ultimo brano che chiude il trittico, Sirènes, i vocalizzi del coro femminile evocano invece l’antico e seducente canto delle sirene su un accompagnamento orchestrale fluttuante e mutevole.
MAURICE RAVEL
Shéhérazade, poema per voce e orchestra
Il fascino dell’Oriente che tanti artisti aveva contagiato nella seconda metà del XIX secolo non poteva lasciare indifferente un esteta come Maurice Ravel. Già nel 1898 il compositore aveva iniziato a musicare un libretto d’opera dal titolo Shéhérazade, portando però a compimento solo l’ouverture. Cinque anni dopo, nel 1903, ispirato dalla lettura dei poemi orientali di Tristan Klingsor (pseudonimo di Léon Leclère), Ravel realizzò il trittico Shéhérazade, poema per voce e orchestra eseguito per la prima volta a Parigi il 17 maggio del 1904. Nelle tre liriche che compongono il ciclo - Asie, La flûte enchantée, L’indifférent - Ravel recuperò la vocalità declamata sperimentata da Debussy nel Pelléas et Mélisande, rivestendo i voluttuosi versi poetici di Klingsor con linee melodiche di raffinato nitore. L’invocazione iniziale del primo poema ci trasporta in un attimo in quell’Oriente favoloso e immaginifico tanto amato dagli artisti decadenti dove l’incanto timbrico della musica di Ravel riesce a restituire il mistero di notti incantate, i profumi inebrianti di spezie e incensi, i colori mutevoli e fascinosi di mondi e popoli lontani, in uno scambio continuo tra parola ed evocazione sonora.
CLAUDE DEBUSSY
Prélude à l’après-midi d’un faune
Il primo capolavoro sinfonico di Debussy, Prélude a l'après-midi d'un faune - composto tra il 1891 e il 1894 - trae ispirazione da un’egloga di Mallarmé, poeta vate del simbolismo e tra i più stimati dal compositore. Il risveglio e le le smanie sensuali del fauno del testo poetico sono affidate alla languida melodia iniziale del flauto, un arabesco sensuale che si libra nel vuoto per poi scorrere via tra armonie diverse in un continuo fluttuare di colori ed evocazioni sonore, seguendo una forma totalmente libera. Se ci fu chi non apprezzò l’ondivaga scrittura di Debussy, con l’indefinibile modulazione della frase melodica, il diretto interessato, Mallarmé, ne sottolineò invece la bellezza suggestiva, sottolineando come la musica avesse prolungato l'emozione del suo poema e ne avesse fissato lo scenario più di qualsiasi resa pittorica.
IGOR STRAVINSKIJ
Sinfonia in tre movimenti
La Sinfonia in tre movimenti fu composta da Igor Stravinskij tra il 1942 e il 1945 e dedicata alla New York Philharmonic Symphony Society. Dopo il debutto, il 24 gennaio 1946 a New York, alcuni commentatori associarono l’opera al periodo storico in cui era stata realizzata definendola una “Sinfonia di guerra”. Stravinskij rispose affermando che in essa erano sì riscontrabili i segni “del nostro difficile tempo, con i suoi violenti avvenimenti, con le sue tragiche alternative di speranza e disperazione, le sue inaudite sofferenze, la sua tensione e finalmente con la distensione e il sollievo”, ma che, tuttavia, non si trattava di una Sinfonia a programma. Nell’organico orchestrale rivestono un ruolo primario il pianoforte e l’arpa trattati come strumenti concertanti nel primo movimento (Metronomo = 160) e nel secondo movimento (Andante). Stravinskij sembra qui privilegiare i contrasti timbrici, tipici della forma del concerto, piuttosto che lo sviluppo tematico, proprio della sinfonia. Dopo la cantabilità a tratti cameristica del secondo movimento, l’ispirazione guerresca, già riscontrata nel primo movimento, torna prepotentemente nel terzo movimento (Con moto) dall’inizio fulmineo e contraddistinto dal ritmo di una marcia pesante e squadrata che confluisce poi una fuga.