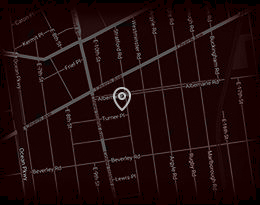Il Belcanto con Marco Filippo Romano e Christopher Franklin (sul podio): 23 novembre 2025

Domenica 23 novembre 2025 alle ore 16.30, in Sala Mehta, il direttore Christopher Franklin e Marco Filippo Romano tornano al Teatro del Maggio per un recital pomeridiano tutto buffo.
Al fianco di Marco Filippo Romano il soprano Aloisia de Nardis.
Sui leggii dell’Orchestra del Maggio le musiche di Gioachino Rossini, Gaetano Donizetti e “Il maestro di cappella” di Domenico Cimarosa.
Firenze, 20 novembre 2025 – Continuano gli appuntamenti sinfonici autunnali al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Domenica 23 novembre 2025 alle ore 16.30 il maestro Christopher Franklin - di nuovo alla guida dell’Orchestra del Maggio dopo il concerto tenuto al Teatro Romano di Fiesole nel luglio del 2008 - e Marco Filippo Romano tornano nella Sala Mehta del Teatro per un recital di canto all’insegna delle musiche di Gioachino Rossini, Gaetano Donizetti e Domenico Cimarosa.
Al fianco di Marco Filippo Romano il soprano Aloisia de Nardis.
Il frizzante pomeriggio musicale comincia con una serie di estratti dalle composizioni di Rossini: in apertura la Sinfonia e “A un dottor della mia sorte”, entrambe tratte da Il barbiere di Siviglia a cui seguono “Per piacere alla signora” da Il turco in Italia e poi, da La Cenerentola, la Sinfonia e “Sia qualunque delle figlie”.
La donizettiana “Signorina, in tanta fretta”, tratta dal Don Pasquale, precede il pezzo conclusivo del recital pomeridiano, ossia il celebre intermezzo giocoso di Domenico Cimarosa Il maestro di Cappella.
Parlando del concerto e della sua interpretazione dei brani scelti, Marco Filippo Romano – che torna al Maggio dopo le recite de La Cenerentola del settembre 2024 – ha sottolineato le caratteristiche del belcanto e dell’interprete buffo, specialmente in questo tipo di repertorio: “La storia del melodramma è costituita da momenti specifici che ne dettano lo stile e le tematiche. Il Belcanto, che si pone dalla seconda metà del ‘700 alla prima metà dell’800, rappresenta sicuramente uno dei punti più importanti della storia della musica in cui i compositori italiani raggiungono il massimo della loro espressività, ereditando lo stile dalla scuola napoletana – di cui l’erede indiscusso che ha ispirato i futuri compositori del genere è Domenico Cimarosa – e gettando le basi musicali del tardo Ottocento. Tra questi, ovviamente, spiccano Rossini e Donizetti che attraverso le loro melodie rapiscono il pubblico: l’uso di colorature, di dinamiche, i tempi rapidi e momenti lirici sospesi creano un’atmosfera surreale, dove agilità e ornamentazioni sono i protagonisti della linea melodica.
Il buffo possiamo definirlo un 'capocomico': colui che essendo, malgrado suo, al centro della vicenda e subendone le conseguenze aveva e ha una visione completa della trama. Essere un buffo significa, per me, avere una missione. Ho sempre pensato che la funzione della commedia fosse quella di far ragionare il pubblico in maniera profonda, abbassando ogni pregiudizio e portandolo a uno stato di “simpatia”, come attrazione verso quelle idee”.
Il concerto:
Nella tradizione teatrale del Settecento, quando il genere comico era considerato di minor importanza rispetto a quello serio, il ruolo vocale del basso buffo era riservato a cantanti ‘di seconda categoria’, che ovviavano alla mancanza di una bella e altisonante voce (indispensabile nell’opera seria) con altre qualità. Al basso buffo era richiesta una sillabazione veloce e la capacità di caricare i versi con esclamazioni ripetute e battute spassose. Tuttavia nella produzione buffa di Rossini questa distinzione viene meno e anche il ruolo di basso buffo diventa un banco di prova per i virtuosi dell’arte canora. Ne è esempio lampante l’aria di Don Bartolo dal Barbiere di Siviglia, ‘A un dottor della mia sorte’, brano ampio e irto di difficoltà tecniche. Nella prima parte dell’aria il sospettosissimo tutore di Rosina, al pensiero che la giovane possa aver inviato un biglietto al suo spasimante, si lancia in un processo alle intenzioni condotto a suon di frasi ampollose che ben si addicono al suo status di dottore. Nella seconda parte, Bartolo è invece impegnato in un mirabolante scioglilingua caratterizzato da un sillabato velocissimo e virtuosistico.
Stesso discorso vale per il personaggio di Don Magnifico, il ridicolo e grottesco patrigno di Angelina ne La Cenerentola. Nell’opera Rossini gli affida addirittura due arie solistiche più una scena con coro. L’aria ‘Sia qualunque delle figlie’, con cui si apre il secondo atto, è un concentrato di comicità pura: un tronfio Don Magnifico si gongola in sogni di gloria, immaginandosi nei panni di suocero del principe impegnato a tenere a bada schiere di sudditi questuanti. Nel corredo del basso buffo oltre a tutori brontoloni, padri invadenti, vecchi infatuati, figurano anche mariti traditi e gabbati da mogli frivole e intraprendenti come Don Geronio ne Il turco in Italia. Il duetto ‘Per piacere alla signora’, tratto dal primo atto, vede contrapposti marito e moglie in un divertente battibecco. All’inizio un infuriato Don Geronio tenta di far valere le proprie ragioni con la moglie Fiorilla, che risponde sicura e piccata. Ma nella sezione centrale del duetto, Fiorilla sfodera l’arma della seduzione e con voce svenevole riesce a intenerire il marito, che nella stretta finale deve arrendersi alle richieste assurde della moglie.
Una scena simile la si ritrova anche nel Don Pasquale di Donizetti, ultimo capolavoro nel genere buffo del maestro di Bergamo. Nel duetto del terzo atto ‘Signorina, in tanta fretta’, il protagonista tenta di impedire alla finta moglie Norina di andare a teatro, beccandosi come risposta una sonora sberla dall’indispettita fanciulla. Di lì in poi il duetto assume nuovi connotati, la comicità esilarante da commedia dell’arte cede il posto alla riflessione e il vecchio infatuato Don Pasquale, ingannato per l’ennesima volta da Norina, si guadagna l’empatia del pubblico. Ad arricchire la carrellata di arie e duetti non potevano mancare due celebri sinfonie d’opera di Rossini tratte da Il barbiere di Siviglia e da La Cenerentola. Sia nel primo che nel secondo caso, Rossini non compose le sinfonie per le opere a cui oggi sono legate. La Sinfonia associata al Barbiere era stata composta originariamente per Aureliano in Palmira, opera seria del 1813 e riutilizzata poi nel 1815 per un’altra opera seria, Elisabetta regina d’Inghilterra. Anche nel caso della sinfonia de La Cenerentola la musica non è originale: Rossini la recuperò da La gazzetta, un’opera scritta qualche mese prima per il Teatro dei Fiorentini di Napoli. In entrambi i casi ritroviamo la struttura tipica delle sinfonie d’opera rossiniane con un’introduzione lenta seguita da un movimento in forma sonata di andamento più mosso e dal carattere vivace.
Esponente di spicco della gloriosa scuola napoletana, Domenico Cimarosa fu un autore estremamente prolifico soprattutto in campo operistico, con un centinaio di titoli grazie a cui ottenne fama e consensi in Italia e nelle maggiori corti europee. Dal 1787 al 1791 fu maestro di cappella alla corte della zarina Caterina II a San Pietroburgo dove compose Il maestro di cappella. Definito ‘intermezzo burlesco’ nell’unica fonte stampa, Il maestro di cappella è assai singolare se paragonato al genere degli intermezzi. L’azione è infatti unica, non si articola nelle consuete due parti da collocarsi negli intervalli dei tre atti dell’opera seria, e prevede un solo personaggio cantante anziché due. Un monologo comico quindi, che vede protagonista un direttore d’orchestra, il maestro di cappella del titolo, nell’intento di istruire a dovere i musicisti per l’esecuzione di un’aria “in stile sublime”. Ma l’inizio delle prove si presenta problematico, i musicisti non conoscono la parte e sbagliano continuamente gli attacchi. Il maestro di cappella è dunque costretto a canticchiare i motivi di ciascuna sezione fino quando tutti i musicisti riescono a imparare la loro parte nel modo corretto. Un ritratto divertente del mestiere di direttore d’orchestra settecentesco che rientra a pieno titolo nel filone delle parodie dell’ambiente teatrale assai di moda all’epoca.